
“Ti porterò nel sangue”. Rilke e Lou Salomé: un amore infinito
Poesia
Marilena Garis e Riccardo Peratoner
Ho tra le mani l’antologia Nuovi poeti italiani 7 curata da Maurizio Cucchi (Einaudi, 2023) e mi sto chiedendo perché dovrei leggerla. Il 2023 è stato l’annus horribilis delle antologie: prodotte in quantità smisurata, ma orfane di qualsiasi pensiero critico e agglomerate con criteri insignificanti, testimoniano una volta di più l’andamento, se non l’andazzo, dell’editoria, soprattutto la cosiddetta maggiore. Anche la poesia deve vendere, questo il diktat. Da qui l’abbassamento della qualità testuale a livello pop o, più modernamente, social, e, contestualmente, il rifiuto di riproporre con nuove edizioni importanti autori del recente passato (che fine ha fatto Ripellino nel suo anniversario?), tantopiù se in dialetto e perciò potenzialmente a vendita limitata; da qui la fioritura del numero delle antologie, di più facile smerciabilità.
L’antologia di Cucchi è la settima di una serie einaudiana che ha sperimentato criteri diversi. La numero cinque fu curata da Franco Loi e presentava undici poeti dialettali, alcuni dei quali di grandissimo valore, e trova in questo la sua necessità; la numero sei, assemblata da Giovanna Rosadini, è l’ennesima antologia delle donne, e cavalca l’onda della lotta per i diritti, ma qualitativamente rappresenta un abbassamento rispetto alla precedente; di gran parte degli autori delle prime cinque, poi, si è persa traccia, a significare l’inefficacia delle antologie odierne rispetto all’unica vera giustificazione del loro esserci, che fa gioire chi è accluso e infuriare chi è escluso: costruire il canone.
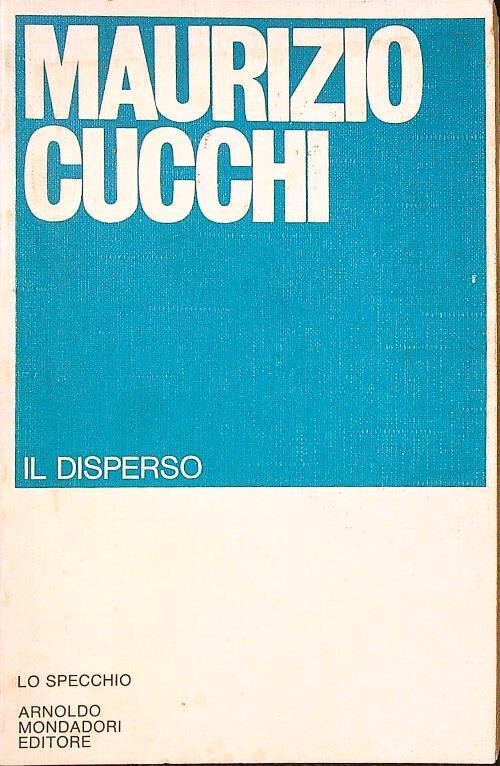
Per quale motivo dunque prendere in considerazione la numero sette? Risposta facile: perché è di Cucchi, il poeta e il critico italiano più influente. Nessuno come l’autore milanese è stato altrettanto capace di imporre un gusto, uno stile, una poetica e, come conseguenza delle proprie raccolte, di collocare autori precisi, continuatori della sua poetica, per formare il canone futuro. Il quale, checché si dica, procede eccome, è già fissato da anni, anche se tutti ne lamentano l’impossibilità.
La poesia e l’editoria sono dunque i due campi in cui si è giocata l’attività di Cucchi e il suo successo come maestro delle cerimonie del canone italiano contemporaneo. La prima affonda le radici negli anni Settanta. Il disperso, opera d’esordio, viene proposto da Giovanni Giudici a Vittorio Sereni, curatore dello Specchio, la collana poetica di Mondadori, ed esce nel 1976 con una quarta di copertina di Giovanni Raboni, che parla di “ossessione” per i temi, di “uno dei più sicuri libri di questi anni”, di poesia urbana e suburbana. La consacrazione dunque è obbligata e immediata, la carriera rapida: il giovane delfino giungerà in pochi anni a decidere i libri della Mondadori, e non solo. L’associazione di Cucchi alla “Linea lombarda” è automatica, forse frettolosa. Leggiamone la definizione di Flavio Santi, citata da Sebastiano Aglieco nell’Anello Critico 2022:
“La linea lombarda: (…) Poesia spiccia, oggettiva, scarna, dritta per la sua strada. Messa ormai nel frigobar delle antologie scolastiche e critiche”.
Ma leggendo attentamente Cucchi, emergono le differenze.
Dell’anceschiana enunciazione di una linea che non sappiamo ancora se esiste, Vittorio Sereni è l’autore oggetto di maggiore appropriazione indebita. Una marea di poeti lo avoca come modello: ma di Sereni balena nelle opere dei sedicenti discepoli solo un alone, riguardante il tono, quel vago rancore per l’epoca, quel disincanto. Nulla del suo sperimentale, innovativo e sempre attivo lavorìo a cavallo tra metro e sintassi sembra riguardarli; tantomeno Cucchi. E Raboni? Quale? Le case della Vetra c’entra con Cucchi? Certo non Quare tristis, coi suoi sonetti tra i più alti del Novecento, con chi ritiene il metro preistoria e la rima improponibile. La forma unica e costante dei cucchisti è il frammento, il testo irrelato, in cui si sia cancellato il prima e il dopo, perché, al contrario di Raboni, non importa ricostruire un contesto. Il male è nelle cose, titolo di un romanzo di Cucchi, basta come dichiarazione di poetica, ed è l’opposto testuale di Raboni, che ha scritto:
“Se mio padre
fosse vivo, chiederei anche a lui: ti sembra
che serva? È il modo? A me sembra che il male
non è mai nelle cose, gli direi”.
Caratteristica specifica di Cucchi è l’indeterminatezza delle situazioni. Non c’è mai abbastanza per capire bene, altroché che Sereni o Raboni. Nel Disperso ciò è conclamato: di cosa sta raccontando? Di chi? Il libro pare un’istruttoria, un’indagine su un delitto, secondo la citatissima definizione di Giudici, ma non si capisce né quante siano le vittime, né di che delitto si tratti, né chi stia indagando. Lo stilema utilizzato fino all’abuso, come ha notato Giorgio Manacorda, è quello dei puntini di sospensione, che marcano la frammentarietà e le omissioni, rendendo astratto il racconto, cioè impossibile. Non c’è nulla da capire, perché non c’è nulla da raccontare, se non calvinianamente il racconto del racconto. Questo è il male: le cose si lasciano elencare, ma mai mettere in una trama, perciò non diventano metafora, né simbolo, né altro eccetto una vaga allusione. La foresta di simboli in Cucchi regredisce a selva oscura, la realtà è bloccata nella sua orizzontalità, mostrando ancora una volta che il realismo è il peggior nemico della realtà. L’unico vero oggetto della poesia di Cucchi è il gesto stesso della poesia, che è il senso. Un altro lombardo, Rebora, ha affermato l’opposto, ma è chiaramente fuori dai radar di Cucchi (mentre Raboni lo elevava addirittura sopra Montale), in tutti i sensi, evidenziandone una selezione “lombarda” assai limitata. Né siamo di fronte al dubbio se si possa comunicare o meno, cosa su cui si sofferma l’ennesimo lombardo tradito, cioè Luciano Erba, soffrendone intimamente.

A quanto pare solo nel 1987 con Donna del gioco, quella di Cucchi finalmente “si farà vera poesia” (D. Piccini), ma forse ancor di più con La luce del distacco del ’90. È accaduto che il poeta ha scritto per il teatro, confrontandosi con la figura di Giovanna d’Arco; e accadrà di nuovo con L’ultimo viaggio di Glenn. In entrambe queste esperienze, e poco altro, la storia è esterna alla poesia, la narrazione si nutre di qualcosa che non è sé stessa: la Pulzella d’Orleans, appunto, e la figura del padre, Glenn, soprattutto prima, durante e dopo la campagna di Russia della Seconda Guerra Mondiale. Il tono rimane quello, il racconto procede per “schegge e brani sincopati” (ancora Piccini) ma è l’elemento esterno a togliere vaghezza alla narrazione. In realtà non esiste uno stile unico nella storia di Cucchi, bensì un’evoluzione, e questo è un merito per un poeta (si veda ancora Montale). Se ne individuano due tempi, forse addirittura tre, comunque un percorso di progressiva pacificazione sintattica e regolarizzazione metrica. La continuità va cercata altrove.
Intanto, nell’offuscamento del riferimento extratestuale, che avviene bloccando lo sguardo sulla scena e sugli oggetti, in una sorta di iperealismo che soffoca sul nascere ogni possibile trasalimento in altezza. L’uso costante di nomi propri, soprattutto topografici, ma anche personali, ad esempio, va in questa direzione.
Per leggere Cucchi si dovrebbe continuamente ricostruire filologicamente di cosa sta parlando: quale via di Milano e perché proprio quella, quale relazione intercorra col personaggio chiamato col suo nome, quale località o industria o quartiere… Ma è ovvio che la strada non è questa, anzi l’opposto: la precisa e continua nominazione maiuscola ha la stessa funzione dei puntini di sospensione, serve cioè a nascondere la narrazione, ad astrattizzare il contenuto. Non potendo capire di cosa sta parlando per mancanza di informazioni, si rimane nell’ignoranza, cioè si capisce l’unica cosa che conta: che non c’è nulla da capire, che non c’è senso. Rimozione cucchista più che reticenza lombarda. “C’è dunque uno schermo ben presente che si frappone fra la voce parlante e la realtà: lo schermo di una visione volutamente caustica, antiretorica, umile, che non perde occasione per dichiararsi” svela Piccini, togliendo la maschera al personaggio unico che parla in questa poesia sempre con la stessa voce, di cui si precisa la descrizione come “figura pigra, indolente, leggermente viziosa, fotografata negli istanti meno sapidi, più insignificanti, di una vita”.
Un altro elemento costante è infatti la meschinità degli oggetti evocati, fin dal primo libro, in forma di elenco. Ciò ha fatto parlare di crepuscolarismo, delle buone cose di pessimo gusto, accostamento a ragione contestato da Luca Cesari. Intanto le “cose” elencate da Cucchi non sono buone, ma brutte, sudice, squallide, danneggiate: le sordide cose di pessimo gusto. Ce n’è in ogni libro, ancora in Malaspina del 2014, dove si dice di “residui fossili, e rivoli/nascosti”, dove ha “imparato a esprimere gli umori”, tra “muri marci/ mucillagini e insetti”, “topi che guizzano e acute muffe”, “lucenti palazzi/verticali (…) infine infestati dai topi”, dove vive una “povera diavola nei suoi pidocchi” nel “fango e macerie e cumuli/di fogliame”. Gozzano utilizza il salotto di nonna Speranza per aprire un varco temporale e connetterci con l’unico segmento in cui è fiorita la rosa che non colse, cioè il passato; in Cucchi invece gli elenchi rimangono su uno schermo (“Tenace sordità delle cose” dice Piccini), danno semmai un sentore di abbassamento, di preferenza appunto per il sordido, anche se forse sta qui un cedimento metaforico: che sia tutta la vita così?

Dunque frammento vagamente relato con la narrazione, tono medio della voce specchio della mediocrità del reale, ambientazione cittadina che contiene tracce privatissime, stile prosastico raramente increspato dal sentimento, autobiografia del quotidiano che vive nella poesia più che nella vita (cioè petrarchismo): ecco il canone. A ben pensarci, vi aderisce l’ottanta per cento dei poeti d’oggi, gran parte dei giovani dell’ultima generazione, alcuni dei quali stanno per essere eletti alle collane maggiori, naturalmente. Scrivono così anche quelli che non hanno mai letto Cucchi, cioè la gran parte, perciò è importante, essendo riuscito a imporre uno stile per osmosi, per sentito dire, orecchiato non si sa bene quando. Un processo di cui avevamo già altre prove: quanti poeti hanno scritto come Ungaretti pur non avendone mai aperto un libro? Certo, la svolta prosastica, frammentaria e diaristica è lontana nel tempo ed ha ricevuto uno scossone determinante con il secondo Montale: peccato che Satura e persino i Diari successivi siano zeppi di rime, di musica e di chiarezza assertiva (aggettivo diventato un insulto per gli accademici d’oggidì), cosa di cui s’è persa traccia. E qui sta il nucleo dell’operazione: per imporre sé stesso come punto di riferimento del nuovo canone, Cucchi ha dovuto cancellare gran parte della tradizione del Novecento. Dove sono i continuatori di Luzi e Caproni, di Bertolucci o Sereni, addirittura di Loi? Anche chi se ne dichiara ammiratore, in realtà ha tagliato i ponti. C’è molta ipocrisia nella poesia italiana, come si vede alla prova dei fatti, cioè dei versi.
Utilizzando il modello della propria poesia, Cucchi sta cancellando le tracce della tradizione attraverso la sua attività editoriale. Non tanto scrivendo di critica, povera attitudine della sua penna: rileggendo alcune sue antologie del passato salta agli occhi una desolante assenza di idee e una banale attitudine scritturale. L’introduzione a Nuovissima poesia italiana, antologia dei giovani curata assieme ad Antonio Riccardi, rivela un’imbarazzante piattezza di criteri e una totale incapacità di scorgere gli elementi del presente della poesia, sciorinato attraverso concetti buoni per un compitino da liceali, in cui si confondono, detto a mo’ di esempio, poesia sperimentale e sperimentalista; tutti poi ricordiamo la convenzionalità delle sezioni e categorie di Poeti italiani del secondo Novecento, che infatti, passate nel dimenticatoio, non vengono mai citate, e l’abisso qualitativo che intercorre tra le schede di Cucchi e quelle di Stefano Giovanardi.
L’acume critico di Cucchi non sta nello scrivere, ma nel gestire. Persino le tante scelte editoriali senza dubbio meritorie (mi viene in mente l’oscar Mondadori dedicato a Rocco Scotellaro, purtroppo corredato da una sua inutile introduzione, oppure, proprio l’anno scorso, la riproposizione di Umberto Bellintani, bel poeta che esiste in parte per merito di Cucchi), l’indirizzo e lo sviluppo della linea futura della poesia, quantitativamente maggioritaria, è ben chiara, ed è cucchista. Persino all’interno della sua generazione, la vittoria è chiara. Certo, si obietterà che lo Specchio Mondadori ha ospitato e continua ad ospitare Giuseppe Conte e Milo De Angelis, persino Rosita Copioli e Giancarlo Pontiggia, ma si sa, un poeta non esiste da solo. La generazione di Cucchi ha un grande merito, quella di attestarsi reciprocamente, a vari gradi ovviamente, e mantenendo i distinguo. Ma ha saputo instaurare quella solidarietà generazionale di cui i successivi, tutti cani sciolti, non sono stati capaci. Ma lo scopo di indirizzare il canone e dargli un nome preciso rimane sempre lo stesso.
Nell’importanza dell’operatore, dunque, sta la giustificazione della lettura della sua antologia, fatta, però, ricercando in essa i poeti che si allontanano dal Canone Unico, per mantenere un rapporto con la tradizione del Novecento, autori che non sono mai mancati, occorre riconoscerlo, nelle scelte di Cucchi, non so se per nobiltà o per calcolo.
Gianfranco Lauretano
*Si pubblica un’anticipazione di un più lungo saggio che comparirà nel prossimo “Anello Critico” (CartaCanta editore)
*In copertina: Maurizio Cucchi ritratto da Dino Ignani